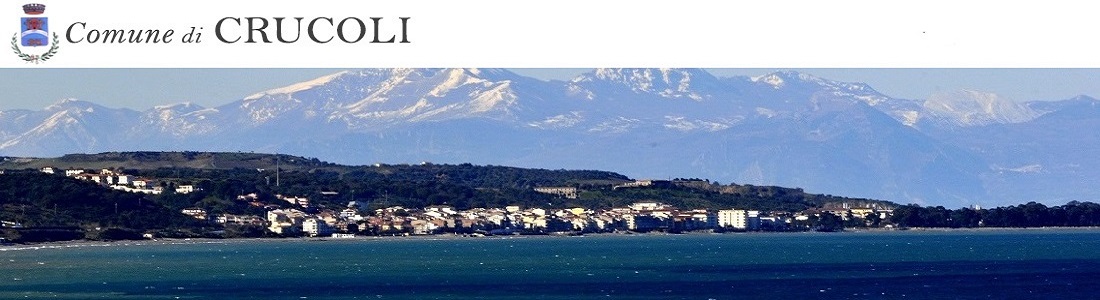Poesie
Di Bartolo Emanuele
Come ... inizia ... la carriera del Poeta
Dalla premessa del primo libro "Filàti sciusi" (1956)
Un bel giorno, l'Autore cominciò ad inviare presso una farmacia crotonese le sue poesie dialettali, con le quali si divertiva a prendere in giro, con garbo e con tatto, personaggi e avvenimenti del luogo.
Dalla farmacia i messaggi avevano diffusione tra il pubblico di cui incontravano la simpatia. Essendo le poesie anonime, nessuno riusciva ad identificarne la fonte ; e poiché l'Autore è immigrato, nessuno gli conosceva o gli sospettava doti poetiche... Da questa circostanza è nata la poesia "Chini sugnu", con la quale l'Autore gioca a rimpiattino con i frequentatori della farmacia.
Alla fine il gioco fu scoperto e l'Autore fu gentilmente sollecitato a i-accogliere le poesie in volume.
LA POETICA
a cura del Prof. Francesco Bellusci
Dalla presentazione del libro "Filati Sciusi" (1956)
Presentare una raccolta di poesie dialettali non è comune impegno letterario e nemmeno facile indagine nei sentimenti e nei pensieri dell'Autore; e più forte diventa il tentativo quando si tratti, come nel caso nostro, di presentare il Poeta Emanuele DI BARTOLO: tentativo forte già che questo singolare cantore, a differenza di altri, pur famosi di nostra terra, presenta una personalità complessa, un armonioso miscuglio di nuovo e di antico di cultura moderna e classica, specialmente greca; sentimenti comuni colorati della più recente e fresca veste, e saggezza antica assimilata fino a renderla norma - massima e alle volte, addirittura proverbio.
Osservatore acutissimo, Emanuele DI BARTOLO coglie la vita in tutte le sue voci e forme: nelle sonore e nelle fioche; nelle piazze e nelle viuzze; nei palagi e nei catochi; nella città rumorosa e nel paesello tranquillo; osservatore acutissimo coglie il lato triste e il festivo - la vita e -la morte - la gioia e la sventura - scene di piazza e di vicoli - cittadini qualificati e cittadini di nessun conto e di ognuno un quadro - una pittura - un bozzetto a tinte ora marcate, ora tenui, ma sempre opportune e tali che ogni concetto è denso dell'umanità del Poeta; e col poeta il più semplice concetto s'innalza e si umanizza fino a creare l'interesse del lettore e più degli ascoltatori, poiché la poesia popolare è più efficace se ascoltata che letta.
Emanuele DI BARTOLO è autentico poeta popolare e come tale felicissimo nella declamazione che somiglia a una narrazione Il fascino che esercitano le sue poesie è proprio in questo elemento della lirica popolare: nulla si perde leggendo; ma quanti profumi si volatilizzano durante la lettura !
Il timbro - la cadenza - il suono stesso della parola - le mosse del volto e degli occhi e della bocca tutto conferisce un necessario ornamento alla poesia popolare - ornamento che determina una singolare simpatia con uomini e cose.
Tali pregi il Poeta di Crucoli possiede a dovizia, e pertanto nei suoi canti oltre a un'alta spiritualità è opportunamente diffuso l'elemento senso - materia - fenomeno. E tali elementi non sono come nelle poesie culte espressi nelle sintesi ardite ed efficaci, ma carezzati - narrati alla paesana in maniera semplice e sobria - sono elementi che nella vera poesia popolare costituiscono la ragione prima e vera della sua eterna bellezza che in veste, a vista, dimessa e rustica, assurge tuttavia a vette e cime candide e serene.
Elementi che il nostro Poeta ha utilizzato con acume e garbo e che rispecchiano le parti più care al popolo che in esse trova se stesso e gli altri - grandi e piccoli - attori di ieri e di oggi - attori grandi come i "monsignori" e piccoli come "u metituru"; quadri di dimensioni ampie e tinte marcate comu "u populu" e quadri semplici e vivaci come "a forgia". Scene robuste e vigorose come "vigilia di Natale", e scene che ti si presentano tutti i giorni in mezzo della via dei nostri paesi come ne "i due galli"; e anche la robusta cultura che prepotente affiora in molti canti è contenuta in limiti angusti, sì che la vena popolare zampilla continua mantenendo vivace il colore e il sapore, manifesto risposto dei vari argomenti
Il vero fascino dell'arte popolare non va ricercato negli argomenti gravi d'intelletto e di indagini che pure non mancano nella raccolta, ma negli episodi - negli incidenti di vita di tutti i giorni - dei quali è tanta ricca la strada e la piazza da mane a sera - dentro e fuori le case - nei templi e nelle povere case.
A leggere i canti di Emanuele DI BARTOLO si ha l'impressione di essere immersi nella vita della città e del paese e non spiace conoscere cose belle e non belle, ma tutte umane perché in ognuna il Poeta ha fatto cadere un tantino o molto della sua umanità. Ed è garbato se narra episodi di incredibile avarizia sorpresa in uomini che dovrebbero combatterla; è pungente amaro acuto nei cenni a quadretti che eccitano le sue qualità satiriche; ma sempre satira cordiale - mai un giambo avvelenato o volgare.
Tutto è, contenuto in linee sobrie e misurate e le tinte non sono mai eccessivamente marcate. Frequente è il tocco felicissimo, sicuro, preciso, adatto ad illuminare una scena ricca e varia di tono e di significato e tutto ti balza innanzi e, se hai dimestichezza con ambiente e persone, ti ci butti in mezzo e partecipi perché il Poeta ha colto nel segno con la sua obiettiva e felice analisi.
Pascale è diventato generale di una singolare truppa di bimbi e giovinetti baldanzosi e arditi, armati di mazze di legno e combatte e annienta una più singolare schiera di nemici metallici e "arruzzatí" e la battaglia, in circolo, ha per sfondo il Duomo e si svolge al suono della Gloria e dura, sempre più accanita e rumorosa, quanto dura la festività della campane. E bimbi e Pascale, deposte le mazze, si disperdono stanchi e attaccano, le "cuzzupe". Sorride il Poeta e col Poeta sorridiamo anche noi.
La nonna che tanto mondo ha visto, e ora ha occhi che più non hanno linguaggio come fontana che più non ha acqua, è immagine frequente e nella poesia colta e nella popolare, ma è qui espressa con grande pietà e senza enfasi giacché il Poeta è profondamente turbato, e, in tale turbamento, la scena si allarga e la pietà aumenta innanzi alla vecchia nonna che, con la mano ansiosa, accarezza in volto i nipoti e, la mano "mpingia nt'i capiddri ricciuluti" e "nu vi nni sa discriviri 'a fattizza".
Alle volte il Poeta tocca corda più sonora. E più si fa largo nella folla e allora le scene e le immagini diventano più drammatiche e più vicine all'anima popolare, assumondo il tono di una canzone a ballo con al centro "u metituru" e la fanciulla, e intorno intorno la folla che guarda gusta e canta. Immagini sincere, reali, vigorose come il mietitore e le fanciulle - sane - robuste - esuberanti dalla voce calda: creature ardenti nella grande fornace del sole di giugno:
"jetta focu u sulu 'e giugnu
e 'ra favucia nt'u pugnu - mi lampìa ".
L'ardore dell'amore non è avulso dall'ambiente; non è finzione, non è reminiscenza letteraria; è sentimento accesso e naturale che si esprime con argomenti opportuni e semplici sì che le due creature, al centro della stagione e dell'ora, assumono forme e caratteri di rilievo e di forza.
Altre volte il poeta canta scherzosamente e sembra voglia divertirsi e divertire e canta "A gulia" e passa da "cirasa" alla ricotta al "cinghialu"; al tocco finale:
"u dottoru l' accarizza e
facennu u pizzu a risu:
nunn' è nenti,beddra mia,
chissa è puru na gulia".
La raccolta è ampia e molto varia, ed ha fiori di tante fattezze e di tanti profumi, ma a sorprenderne il carattere più diffuso nei canti si resta, è vero, lieti e sorridenti, ma con nel fondo dell'anima una forte malinconia. Perché Emanuele DI BARTOLO è un temperamento eminentemente melanconico.
Il dialetto è quello comune alla zona montana e marina che da Cariati si stende verso Bocchigliero e poi a Crucoli e giù giù fino a Cirò e Crotone. E' un volgare alquanto aspro e risente ancora del monte e delle spiagge selvagge non avendo, nel passato, avuto contatti con parlate più gentili e più ricche. A differenza del casalino apriglianese, che in questi ultimi anni ebbe nel compianto Ciardullo il Poeta dolcissimo della serena, Sila e del placido Crati, e del nicastrese che con Pane ebbe il poeta della malinconia della valle e la profonda gioia delle montagne del Reventino e del Catanzarese che con Butera canta e racconta con andamento agilissimo e fresco, dialetti resi dolci dall'uso frequente di cantori e poeti e dalla vicinanza dí grandi centri di cultura e commerci, il dialetto dei canti di Emanuele di BARTOLO è la favella originaria e rude comune ai paesi dove il poeta vive lavora e canta quando:
"si cc'è l'estru chi nt'u coru scinna
sula sula 'a poisia sì conza e squatra;
idei e verzi calanu nt'a pinna
comu cirasi: l'una appressu l'atra".
Vi abbondano le consonanti doppie con prevalenza di gutturali e dentali; in compenso è frequentissima la doppia labiale e la sibilante raddolcita ti sembra un vezzo delle labbra, una carezza tenera e dolce.
Crotone, 26 marzo 1956.
LA POETICA
a cura di Nicola Caporale
Nato il 25 marzo 1901, a Crucoli, un paesino della provincia di Catanzaro, di circa 3.700 abitanti, si trasferisce a Crotone per esercitarvi la professione di medico-pediatra, e qui muore il 10 di marzo 1978.
E' uno dei tanti professionisti che, per vivere, sono costretti ad abbandonare la propria terra, recando seco un mucchio di ricordi e di speranze, di sogni e di entusiasmo per affrontare un mondo nuovo e sconosciuto. Crotone è una città in crescita, dove un medico può espletare la professione con maggiore libertà. Vi arriva con la mente linda, col cuore pronto a captare qualunque onda lo colpisca e, soprattutto, con acuta intelligenza, esercitata già a cogliere il reale, fosse esso un vizio o un'accidentale azione di vita, a pescare il ridicolo nel prossimo oppure ad acciuffarvi una satira. Satira che, diciamolo subito, non è mai cattiva, ma è sempre garbata e benevola.
Non dimentichiamo di trovarci dinanzi a un medico, che, come tale, è tutti i giorni immerso in un mare di grande umanità.
Il vero Di Bartolo è lì, tra gli uomini diguazzanti nelle scure acque della miseria, si chiami essa dolore o malattia, spilorceria o cattiveria. Il Nostro, inoltre, è un cristiano che non ha vergogna, come tanti altri cristiani, di manifestare la Fede. E, come "cristiano", non usa la frusta nella satira, né la grancassa nell'esaltare la natura.
Lo definirei un francescano. SI, un francescano nel lenire il dolore, nell'euforia del creato. Ma è un'anima complessa, un misto di fede e di pessimismo, un pessimismo che gli viene dalla conoscenza dell'uomo che è, in fondo, un essere fragile che dimentica presto. Un "amarume" senza uscita che egli trattiene come patina invisibile nel cuore.
E la Fede?
Tu la trovi negli stessi solchi umbratili della miseria. A volte ci ride sopra, ma tu avverti, sotto sotto, quella nota falsa, piena di lacrime cacciate nel profondo. Pure da questo risali all'Essere supremo che ne permette quel tale scempio in mezzo alla società, se non fosse che la tua stessa intelligenza ricorda il libero arbitrio, il quale, in ultimo, si rivela non solo inutile, ma debole e confuso destino, che sfugge alla possibilità umana cui si manifesta una forza sconosciuta e misteriosa che, senza sentire, opera nella mente umana.
E allora?
Di Bartolo col suo dialetto, non ancora macchiato di un italiano bastardo, raggiunge livelli sublimi, che ne fanno un vero poeta popolare. Ecco la ragione per la quale Di Bartolo non si può chiudere entro limiti di un saggio. A noi basta accennare fugacemente ai meriti della sua poesia per ricordarlo alla nostra gente o addirittura per farlo conoscere prima che la cenere dell'indifferenza ne seppellisca opere e nome, come accadde per altri ingegni nostrani che hanno dato lustro alla Calabria.
Ma parlare di Di Bartolo è come tuffarsi in acque difficili e pericolose. La Musa lo trae di qua e di là, per palazzi superbi ed umili tuguri, dentro anguste arcate di un tempio e le superbe colonne di un bosco, dal terribile frastuono d'una tempesta al tranquillo mormorare d'un ruscello. Ma Di Bartolo resta sempre un paesano, un figlio di paese, dove la vita non ha fretta, e le cose si manifestano cosi come sono, dove l'occhio si affina nell'osservare sia il piccolo che il grande.
E, ricordiamolo ancora, ci troviamo di fronte ad un medico cui nulla sfugge. Qualsiasi oggetto o minima manifestazione egli li coglie con abile rapidità e li presenta al cervello nel sagace esame oltre che nel cuore che ne valuta la rappresentazione di un mistero. E questa sua professione di medico non si basa soltanto nella rigidità scientifica, ma anche su l'intuizione, che è, poi, una forza occulta e misteriosa, la quale scorre tra la cosa e la nostra sensibilità, ma soprattutto su la certezza di un legamento che portiamo dentro di noi e che è comune a tutto l'universo; un'osmosi sottile tra l'esterno e noi.
Il Nostro ebbe in dono dalla natura questa specie di stimolo in gran copia.
E che non coglie Di Bartolo da tanta varietà naturale?
Tu mmidia risenti 'e ssi zumpi
Diligente e acuto osservatore, raccoglie nel suo sacco capace ogni voce, sia essa di un "canario" oppure di un temporale, di uno sciancato, che di un aitante giovanotto, di una brezzolina, che d'una parolina sussurrata all'orecchio dell'amata. Qua, di una vecchia giumenta, condannata a passare quel poco di via che le resta, entro uno spazio stretto; li di una bambina condannata a trascorrere la vita attaccata ad una sedia. La pena altrui diventa pena propria, e lo affligge fino a farlo cadere a volte nel pessimismo.
chi zùmpanu e vanu ccu lèggia
movenza... Nchiovata a na seggia
tu, povira piccola, campi ...
Una bambina "'nchiovata" ad una sedia ed un "canario"; l'agilità con cui l'uccellino salta da uno staggio all'altro di fronte all'immobilità della infelice poliomelitica. Qui il dramma: il "canario" che saltella e canta, e la povera piccola disgraziata che ha le gambe inerti e morte e, pertanto, ha una vita morta. Là, una vitalità effervescente, qui la nascosta miseria d'una impotenza insormontabile. Da questo spettacolo disumano ne nasce non solo tristezza, ma tanta miseria mista ad un sottile pessimismo, che intacca pure la coscienza religiosa del lettore. In questa "caggia" il poeta rivela la sua forza e la sua grande umanità. Del resto la sua vivace fantasia e la sua sensibilità aderiscono al vero, fino a trasformare l'oggetto reale in oggetto fantastico.
Di Bartolo resta poeta popolare anche là dove la poesia si aggrappa al fascinoso. Inoltre la musa con la sua mobilità ora tocca un fiore, ora uno stato economico-sociale, ora intinge la penna nel magico traendone una favola, ora è prepotentemente attratta dalla Caritas.
Vario e complesso il suo poetare, che sa trarre una lirica perfino dall'aridità di un tema. Né resta alla superficie, ma vi si cala dentro per trarne la verità nascosta. Ciò accade per quella grande umanità che il poeta serra dentro. Vedi, per esempio, "'A timpesta": te la presenta con tale vigore che tu resti assorbito addirittura dal grandioso fenomeno naturale.
Davanti a te sta la maestosa solitaria quercia cui sta vicino un querciolo anch'esso solitario. La furia del vento è spaventosa. Una lotta tra la quercia grandiosa e il vento è immane: il vento che cerca, ad ogni costo, di distruggere la quercia, e questa che gli resiste dimenando le enormi braccia, ritirandole e allungandole nell'aria come per schiaffeggiare l'invisibile forza, ed or si torce e si contorce, ed or si raddrizza con violenza.
Dall'alto domina accanendosi la tempesta con fulmini guizzanti a zig-zag verso quei lottatori. Ma la lotta si è anche attaccata al vicino querciolo e su tutto. Il frastuono dei tuoni e la baraonda della pioggia, violenta e grossa, che scava solchi profondi quasi tracciati dalla punta di un aratro
'A cerza si torciva, si chjcava
mo' ccu nu vrazzu, mo' ccu n'atru vrazzu
e 'ru ventu, ostinatu, 'a zzinzuliava
comu nu canu zzinzulìa nu strazzu.
E' tutto un inferno. Ma dopo tanta lotta, tanto fracasso la tempesta si placa e ritorna la calma; e il querciolo? Giace li, per terra, sradicato, tra le braccia della grande quercia, alzando i poveri moncherini delicati, spezzati dalla violenza del vento. E da questo crudele spettacolo tu ricevi la stessa commozione umana quasi in quel querciolo tu vedessi un esserino debole e innocente
Si l'è portatu appressu ... l'ha torciuta
e l'ha stoccatu 'u trunchiceddru a dui.
A 'ri pedi d'a cerza l'ha cogghiuta
piatusa 'a spina, mmenz'i vrazzi sui
La grande quercia, tutta strapazzata, per conto suo, ha pur la pietà per lo sventurato che giace moribondo ai suoi piedi, come un suo figlio e lo consola "piatusa" come può. Pietosa dice il poeta, e ti riporta alle tempeste che investono gli uomini: umanizzando le cose, commuove il lettore. Intanto la tempesta è passata e
L'acqua chi, a cocciu a cocciu, gucciava
d'i pampini mpunnuti tantu ntantu
a chi 'na spera 'e sulu mbriddrantava
aviva 'ra mestizza c'ha 'ru chiantu.
Diventa tenero Di Bartolo anche quando lo invita la natura come se la terra gli parlasse con l'erba e i fiori, con le ferite e la piana verdeggiante, e tu ti plachi quasi dopo una sfacchinata nel sole di luglio, ti siedi all'ombra e ti compiaci della vasta pace che regna intorno. Ma il Nostro non si ferma qui. Perfino il campanaro lo commuove.
Iu t'aju nt'u coru, t'aju sentutu
lacrimari, ccu mia, dui vecchj cari
ed amurusamente richiamari l'anciuli,
ntornu a n'anciulu perdutu!
E poi vi sfilano i Paesani: il fabbro ferraio, ìl calzolaio, e, ancora, il lampionaio, o il ritorno del nonno. E sono veri e prodigiosi ritratti e vignette. Né vi manca l'umorismo come nella "Littara a lu Viscuvu", oppure la morale che ti caccia fino alle piccole cose come in "'U mortalu". A volte ti trovi all'improvviso davanti ad un componimento grave, imbottito di filosofia come in "'U sonnu" in cui si domanda, dove vanno i sospiri, i pensieri quando ci addormentiamo, e i desideri
Ddruv'è chi va 'ra negghia fitta e griggia
d'a smania, d'a ncertizza e d'a pagura?
E tutta l'ansia che ci affligge? E qualche bioccolo di pessimismo lo cogli sugli spini del suo pensiero. E' medico e il suo pessimismo vien fuori assistendo ai dispiaceri umani e perfino alla morte.
Pessimismo a volte leggero e a volte pauroso. Infine nello stesso componimento ringrazia il sonno che ci fa dimenticare la vita ed esprime il desiderio di potere soffiare una sera su l'ultima lucerna.
Oh! potiri, nta n'alitu, jusciari
na sira, subba l'urtima lucerna!
S'addormisciri e po' si risbigghiari
come ogne jornu, na matina eterna!
Di là dalla vita! Vi senti la sua religiosità che non è un piagnucolone come tanti, né un miscredente falso per dar tono alla poesia.
E' sincero sempre. Anche la poesia te la costruisce con calma e misura. In Di Bartolo il poetare ti richiama alla mente il poetare dei classici. Chiarezza, serenità, contemplazione, scritta da uno che la vita conosce, e vi dedica perciò tutta l'anima e l'intelligenza. Ne nasce una poesia limpida, che ti riporta a giornate serene e luminose, nelle quali il tuo cuore si lascia andare, godendo di tanta luminosità e serenità, anche se tale atmosfera venga segnata da una frustata, quale può essere la satira, come abbiamo già detto, oppure qualche richiamo morale che vi scaturisce naturalmente, o il leggero sfumato umorismo affabile che, del resto, si diffonde lungo le pagine dei suoi libri.
Senti l'elevatezza spirituale della natura che è poi la tua spiritualità, come senti dolcezza del vivere, dell'essere stato creato, onde esaltando esulti.
Se poi t'imbatti nel sentimento di amore, resti colpito per la delicatezza e la pulitezza con le quali lo canta. Per esempio in "In ritorno", cosparsa tutta di un velo sottile di malinconia.
E "A coniceddra" che riesce a commuoverti seriamente?
Si tratta di un tabernacolo fuori paese che contiene la figura della Madonna Addolorata, con un lumino ai piedi, davanti alla quale da dieci anni una povera mamma si reca.
N'atra Madonna addolorata, 'n pena
ddruva 'a Mamma 'e Gesù va 'd ogne sira.
Sia che il tempo è bello, sia brutto ella va, s'inginocchia e parla con la Madonna, come con una sorella. Una mamma con la Mamma universale che sente la pena e il dolore universali e sa comprendere la pena dell'altra madre. Dieci lunghi anni di ansia, di dubbio, di disperazione.
A ra Madonna ch'è sutta l'olivu
va cerca, tutt'i siri, nu responzu
- Dimmillu, ppe pietà ch'è sempi vivu
....
E' vivu? E' vivu? ... Fammi na cumperma!
L'affidu a Tia, Madonna d'i Doluri.
E si è...
Una madre, una guerra, un figlio disperso. Qui il dramma si allarga all'infinito, la desolazione t'immerge, il dolore ti accoppa. A chi rivolgersi più? Al Governo? Alle Autorità militari cui aveva affidato il giovane figlio? Costoro hanno detto la loro parola: disperso! E si sono cacciata la responsabilità. Nei registri vi sta con inchiostro nero la parola definitiva. E il cuore della mamma? Il cuore della mamma non chiude il registro. Veglia, spera, e tutta la sua vita è li, ai piedi dell'Addolorata! Lei sola può capire, perché anche Lei ha perduto un Figlio.
"E si è... ". Non pronunzia la parola lugubre, perché il cuore le si ribella. Un velo nero ingombra l'anima, e quel sottile e vago senso misterioso della morte non le fa compilare la terribile parola "morto". Superstizione? Sospetto? Entrambe le parole tagliano il participio nella mente. Non bisogna dirla, la parola; chè il dirla richiama la Morte.
Cosi la parola non viene detta. Tu stesso sei preso dall'angosciosa e triste scena, e resti senza parola anche tu.
Ma passiamo alle canzoni composte per essere cantate accompagnate dalla zampogna
Canta, canzoni mia,
... a lucia, 'a gioia, 'a vita.
Che è in fondo tutta la sua poesia: cantare la luce, la gioia, la vita per comunicarla agli stessi derelitti, agli stessi viziosi, agl'inetti, affermando che la vita è gioia, amore verso gli altri, verso tutto e tutti. Verso coloro che soffrono per un dolore, per una speranza perduta, per le lacrime versate.
Il poeta si vede, ora, nei panni di un cenciaiolo che va di casa in casa a raccogliere i cenci, cioè i sospiri, le lacrime e le speranze perdute, regalando in cambio un fremito di stelle, canzoni di grilli, stille di rugiada, mazzolini di verbena, la prima luce della marina, la luminosità della luna. Egli ha per ogni dolore una sua medicina, che è la poesia, lenitrice d'ogni dispiacere. Ed anche l'Amore. Amore cristiano che si scioglie come pioggia su tutto l'universo, su tutta l'umanità dolorante, come dopo la tempesta il mare si veste di luce.
Comune di Crucoli (KR) - Sito Ufficiale
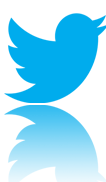 |  | Via Roma, 6 - 88812 Crucoli (Kr) - Tel. (+39) 0962 33274 Fax (+39) 0962 33090 - |  |